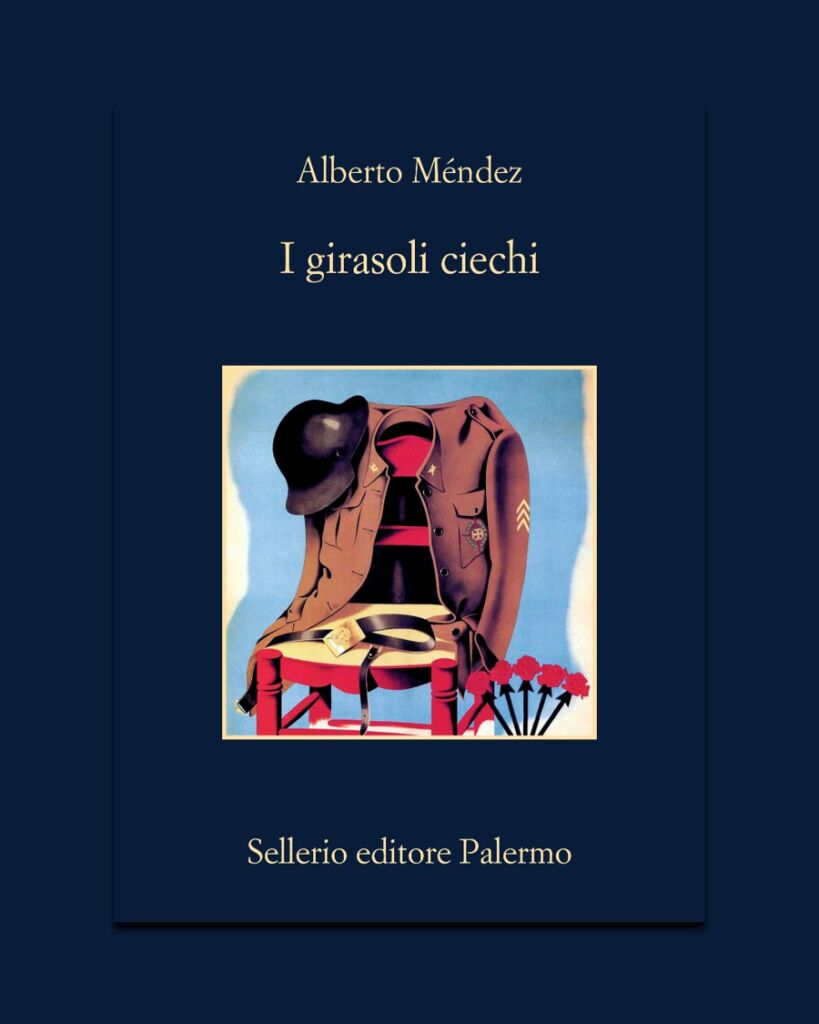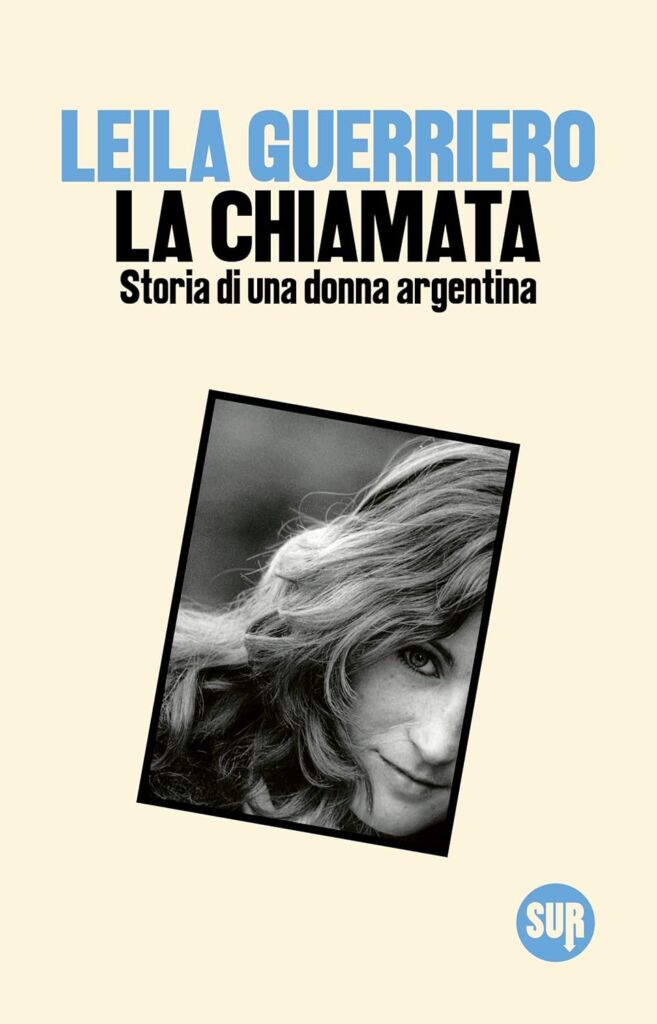Per fortuna non tutta l’editoria italiana ritiene che esistano solo i gialli, spesso scritti e pubblicati con la speranza che diventino una serie televisiva, e ogni tanto compaiono negli scaffali delle librerie testi di qualità che fanno pensare. Ultimamente ne sono usciti due che pur trattando di periodi storici diversi e di avvenimenti accaduti in continenti diversi hanno la comune caratteristica di porre dubbi, di far riflettere, di dimostrare che il mondo della politica e dello scontro non è semplicemente bianco o nero costellato com’è da zone di grigio e di ombre. Due libri che trattano uno, “I girasoli ciechi “ di Alberto Méndez, della guerra civile spagnola andando al fondo emotivo d’una tragedia che ha avuto un ruolo importante nella presa di coscienza antifascista; basti pensare alla frase «Oggi qui,domani in Italia», pronunciata il 13 novembre 1936 da Carlo Rosselli a Radio Barcellona, che con la quasi contemporanea morte del perugino repubblicano Mario Angeloni avvenuta in quella guerra segna in qualche modo la volontà di passare dalla cospirazione alla lotta armata contro il fascismo. L’altro, “La chiamata” di Leila Guerriero, racconta una storia vera vissuta nell’Argentina al tempo della dittatura dei generali e in Spagna tra i tanti esuli latinoamericani che vennero accolti in Europa, Umbria compresa, divenendo parte della vita sociale e politica dei paesi e città che li accolsero.
“I girasoli ciechi”, edito da Sellerio con una postfazione di Adriano Sofri, meritoriamente ristampato dopo che una precedente e lontana uscita era passata inosservata, non poteva che stare nella selleriana collana de “la memoria” con la bella riproduzione in copertina di un manifesto della guerra civile spagnola perché proprio di questa parla. È un canto doloroso sulla guerra civile, quattro racconti brevi ambientati nell’immediato dopoguerra spagnolo tenuti insieme da trame sottili a formare un romanzo perfetto. Un libro sul quale Méndez deve aver meditato a lungo alla ricerca d’una prosa raggelante condensata in un romanzo breve a riprova che i libri non si comprano tanto al chilo e che, come in questo caso, la poesia e il capolavoro si annidano ovunque. Anche nella memoria custodita in personaggi sfiniti dalla follia della guerra che decidono di non farne più parte e – come i girasoli ciechi non cercano più il sole girandosi verso esso – abbandonano senza meta la carneficina di uomini, donne, sentimenti che fu quel prologo della seconda guerra mondiale.
Anime vaganti come il capitano dell’esercito franchista che, pur trovandosi dalla parte dei vincitori, si arrende ai vinti in fuga il giorno prima della loro sconfitta, o come il giovane padre poeta in fuga verso la Francia che persa nei Pirenei la moglie durante il parto non vuole più rimanere a forza in «questo lato della vita» e si lascia morire accanto a lei e al figlio lasciando tutto scritto «per spiegare a chi ci troverà che anche lui è colpevole, a meno che non sia un’altra vittima», o nel marito che vive nascosto nell’armadio di casa.
È la forza della sconfitta, a tenere unite le vicende de “I girasoli ciechi”. Romanzo asciutto e poetico, profondo e affilato dimostra che poesia e senso si possono annidare anche nelle pagine conservate da una persona, iscritta al Partito comunista spagnolo, che ha preferito vivere nell’ombra occupandosi della famiglia, del lavoro nell’editoria e, lo si scopre con questo libro, meditando sulle parole di un testo che racconta il dolore che nasce da una sconfitta e che, come tutti i dolori, deve essere vissuto fino in fondo per essere elaborato. Non per accantonarlo ma per riuscire ad andare avanti con esso accanto. Com’è probabile sia successo ad Alberto Méndez con il suo necessario romanzo pubblicato in Spagna nel 2004 poco prima della sua morte. In un momento della vita nel quale si è, forse, ricordato di quanto aveva scritto a proposito della trasparenza e fragilità del silenzio che lascia passare tutti gli sguardi: «Il silenzio è uno spazio, una cavità in cui ci rifugiamo ma nella quale non siamo mai in salvo». Decidendo che con il reale che «a poco a poco» si alterava era giunto il momento di rompere il silenzio e di far conoscere questa memoria della guerra civile spagnola diventata in Spagna un successo editoriale grazie al tam tam dei lettori senza che Méndez abbia fatto in tempo ad accorgersene.
Dalla Spagna all’Argentina per rendersi conto che più spesso di quanto si creda capita nella vita d’essere portati a dividere il bene dal male ignorando che in mezzo ci sono tante altre gradazioni. La militanza politica intorno agli anni ’70 era uno dei luoghi dove le sfumature non esistevano. “La chiamata”, della giornalista Leila Guerriero, edito in Italia da Sur, racconta invece quello che in quegli anni drammatici è successo a Silvia Labayru in piena dittatura militare argentina conducendo proprio in quella zona d’ombra. In quel luogo del sentimento e della storia nel quale è bene sospendere il giudizio (pure quello che fa dire chi sono io per giudicare) osservando e ascoltando ciò che in Argentina è successo e, come la storia ha innumerevoli volte insegnato, può sempre riaccadere.
Ma chi è Silvia Labaryu? È una ragazza ventenne e avvenente incinta di sei mesi, militante montoneros, imprigionata dal regime argentino all’Esma, scuola per cadetti trasformata in luogo di “rieducazione” e sevizie dov’è costretta a partorire su un tavolo, torturata, violentata. A differenza di quanto successo ad altre e altri, Silvia non viene gettata da un aereo in volo, e nemmeno le tolgono figlio appena nato per darlo a qualche coppia vicina al regime: lo consegnano invece ai invece ai nonni materni.
Indotta a lavorare per il regime dice «non ho fatto arrestare nessuno», viene ridotta a schiava sessuale costretta a fingersi sorella del suo seviziatore uscendo con lui per cenare e ballare e infine viene mandata in esilio in Spagna. Ed ecco che quando si è autorizzati a pensare che tutto sia finito, il non essere stata uccisa, il figlio che non le hanno tolto, «la maledizione della bellezza, per la quale ha pagato un prezzo così alto», il bisogno di sopravvivere diventa un marchio che genera sospetti tra gli altri esuli in Spagna e gli oppositori, comprese le “Madri di Plaza de Mayo”, rimasti in Argentina. «Eravamo sopravvissuti, quindi eravamo per forza dei traditori», confida a un certo punto Silvia a Leila Guerriero, e mentre racconta i primi anni della vita in Spagna parlando di se stessa non dice «mi sentivo libera», ma «ero un’appestata», rimanendo però decisa a raccontare «devo farlo, e lo farò con te», avvisa. Una vicenda complessa e agghiacciante vissuta in anni complessi; fatta di politica, militanza, bellezza, infedeltà, affetti, sesso, figli, genitori, violenze comprese quelle sessuali, che sono tali anche quando per costrizione ti fanno fare quello che non vorresti senza il bisogno d’essere brutali.
Leila Guerriero, una bambina al tempo della dittatura militare argentina, ha scritto che il suo è stato il «tentativo» di scrivere «il ritratto di una donna». Tentativo riuscito molto bene anche perché osservato da una giusta distanza, grazie alla quale il buon giornalismo d’inchiesta è diventato autentica letteratura in un libro nel quale evita di giudicare prendendo posizione ma cerca solo di narrare una storia vera e diversa da quelle che si è sentito raccontare su quanto successo in Argentina durante la dittatura militare. Per farlo si è dovuta immergere nella vita di Silvia Labayru svelando da una prospettiva diversa dal solito un periodo storico, la condizione femminile vissuta in uno stato di imposizione, il passaggio di una giovane donna e madre attraverso quegli anni sia quando era preda dei militari sia quando da esule era esposta al giudizio degli altri esuli e nel 2018 è tornata da donna adulta in Argentina a denunciare in un’aula di tribunale gli abusi subiti durante la reclusione.