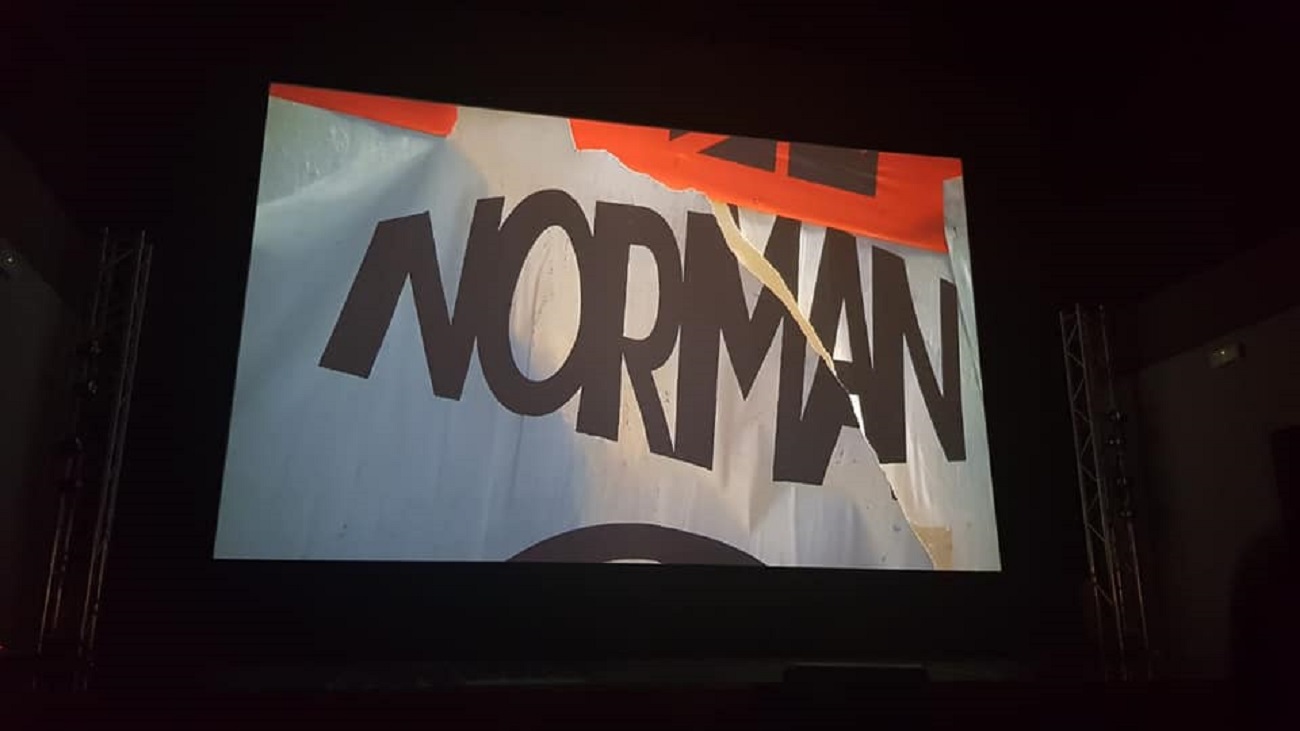Questo articolo è stato pubblicato il 23 aprile 2018 da una testata che non è più on line. Lo riproponiamo oggi, quando rimbalza la notizia che nemmeno i muri del Norman ci sono più, demoliti per fare spazio a delle villette.
Sono successe due cose che sollecitano curiosità e interesse nell’insenatura tra la fine dell’inverno e questo inizio di primavera. Sono successe a distanza di poco più di un mese l’una dall’altra. Sono successe a Perugia ma vanno al di là del luogo che le ha viste nascere. Perché parlano di una parte d’Italia che è sparsa tra Aosta e Siracusa, di un pezzo di storia che scorre sottotraccia e nutre radici, di rapporti tra generazioni e di molto altro ancora. Sono successe contemporaneamente in maniera del tutto casuale; perché sono scaturite da attitudini diverse e hanno regie differenti. Ma sono accomunate da tre peculiarità, oltre che dal tempo che le ha viste dare alla luce: sono due documentari, sono entrambi indipendenti, e vedono protagoniste persone che vanno alla riscoperta di luoghi, tempi e significati che non ti aspetteresti: loro, trentenni o giù di lì, che si mettono a ritessere i fili degli anni novanta del secolo scorso. Di una di queste cose, il documentario sull’ex Cim firmato da Andrea e Ivan Frenguelli, abbiamo già parlato. Dell’altra, l’opera di Nicola Bedont “The story of Norman”, che ripercorre la vita di un locale dove ha suonato mezzo mondo, proviamo a farlo qui, con un occhio e un orecchio anche alla prima, perché in qualche modo viaggiano in parallelo. Lo faremo servendoci di tre oggetti strani per una pubblicazione di questo tipo: due versi di canzoni e il titolo di un libro.
Buffalo Bill
«Avevo pochi anni e vent’anni sembran pochi,
poi ti volti a guardarli e non li trovi più»
Francesco De Gregori, Buffalo Bill
Il Norman, come l’ex Cim, era un luogo frequentato da giovani. Il ventenne dei novanta che lo frequentava, ci andava con naturalezza e per una serie di ragioni che non sapeva, ma che erano dense come un romanzo di formazione a rivederle scorrere oggi su grande schermo. Al Norman si sono visti suonare i Dinosaur jr e i Fuzzotones, i Marlene Kuntz e gli Afterhours. Dopo il concerto si ballavano i Doors e i Red Hot Chili Peppers, i Cure, i Pixies e Bob Marley. Al Norman il ventenne che lo frequentava ci andava perché lì trovava il Norman. Che non era riproducibile, non aveva eguali nel raggio di almeno un paio di centinaia di chilometri e forse anche oltre. Il Norman era un’oasi per chi cercava un certo tipo di atmosfere, che non erano esattamente quelle che andavano per la maggiore. Il Norman era perfetto nel suo incasinamento per una serie di persone: sui muri si andavano accumulando negli anni i manifesti dei gruppi che ci avevano suonato. Lo strato di carta e colla si ispessiva via via componendo un tazebao permanente che andava ben oltre la materia: pareva vita vera che si staccava dalle pareti e ti veniva a toccare. Al Norman si mescolavano dark e punk, metallari, fricchettoni e cani sciolti. Al Norman non suonavano solo i grandi nomi – che spesso non erano ancora diventati grandi ma stavano proprio sul punto di sbocciare -, quelli che scandivano la storia della musica di quel periodo; al Norman suonavano anche le band locali alle prime accordature: lì, per dire, hanno fatto il loro primo concerto i Fast Animal And Slow Kids. Il Norman stava dentro la storia di quel momento. Solo che né chi lo frequentava né chi lo gestiva ne aveva probabilmente contezza. Perché, appunto, «vent’anni sembran pochi, poi ti volti a guardarli e non li trovi più». Occhio, però. Non è solo una questione di anagrafe. È che gli anni novanta del novecento non sembravano tutta questa gran cosa a viverci dentro. I grandi ideali erano in via di dismissione da almeno un decennio e quello che c’era stato sembrava assai meglio del presente: il ‘68 e il ‘77 sembravano dei giganti a confronto. Sì, c’era stata l’occupazione delle università a cavallo tra la fine dell’89 e l’inizio del 1990, la Pantera, ma era finito tutto presto. Insomma, pareva di stare scivolando giù. E in effetti si scivolava. Le basi del precariato come condizione esistenziale si sono cominciate a mettere lì. Però c’era anche molto altro. Solo che la generazione che ci stava dentro non se ne accorgeva. Ci voleva il regista di “The story of Norman”, Nicola Bedont, ventisette anni oggi, per far tirare fuori a Fabrizio Croce, fondatore e anima del locale, che in quel posto veniva scandita la storia, musicalmente parlando e non solo. Perché, dice Croce: «In quel momento c’era uno scambio continuo tra musica e società, tra arte e società». Già, ma la generazione del tempo non se ne rendeva conto a pieno, lo viveva e basta. Anche per questo i novanta non li trovi più. E desta stupore che un meno che trentenne invece, si metta a scavare oggi per ritrovarli. Nei novanta più che altro i ventenni cominciavano ad avvertirlo lo scivolamento. Ed erano aiutati, in questo. Per questo non li hanno visti più, i loro vent’anni. Forse non hanno più voluto vederli. Non è solo una questione di anagrafe, appunto.
La fine della storia
Nel 1992 uscì un saggio che fece molto parlare in pressoché tutto il mondo. Lo pubblicò il politologo statunitense Francis Fukuyama, s’intitolava “La fine della storia”. Tre anni prima era caduto il Muro di Berlino e si era dissolta l’altra parte di mondo, quella che faceva riferimento all’Unione sovietica e al cosiddetto socialismo reale, che era stata in competizione con le democrazie liberali dell’Ovest a partire dalla fine della seconda guerra mondiale. Fukuyama, come ben sintetizzato dal titolo del suo libro, teorizzava che i giochi erano fatti, l’occidente aveva vinto e il benessere garantito dall’economia di mercato, finalmente vincitrice e libera di espandersi, avrebbe esteso i suoi benefici a livello planetario. La storia era finita, insomma. Stop. C’era però chi, pur non avendo mai guardato all’Urss come a un modello, avvertiva tutte le storture, le disuguaglianze, i conformismi nefasti delle democrazie liberali. E il fatto che la storia fosse considerata chiusa così, veniva vissuto come una visione claustrofobica, un’amputazione di possibilità. Significava che non c’erano vie d’uscita. Bene. Nel documentario di Bedont non si fa alcun riferimento a Fukuyama. E neanche Fabrizio Croce – la cui lunga intervista che fa da filo conduttore e continuo contrappunto alle altre numerose voci presenti nell’opera, è anche una ricostruzione storica di quegli anni – fa cenni in tal senso. Però, riguardando i novanta scorrere su grande schermo oggi, seppure da un punto di vista così particolare come quello di Bedont, si respira che il Norman era, inconsapevolmente, una ricerca d’altro. Era come se andare lì significasse dire no, la storia non è finita perché quello che ci danno le vostre televisioni e i vostri modelli non ci piace. Infatti il Norman era unico nell’oceano di posti in cui si respirava a pieni polmoni l’acquiescenza alla teorizzazione della fine della storia, il conformismo dell’uscire-in-tiro il sabato sera. Al Norman ci andavi perché cercavi altro. E lo trovavi. È anche questo il motivo per cui nel documentario di Bedont i frequentatori di allora ritrovano finalmente, e senza cedevolezze alla nostalgia, i loro vent’anni. Li ritrovano sotto una luce nuova. Ci voleva forse un ventisettenne di oggi per rimetterli a lucido. E allora emergono i ricordi delle “scalette” o dei muri. Sì, perché al Norman si accedeva scendendo una dolce e ampia rampa a scale larghe che si rivede nel documentario. Quella rampa pullulava di gente che beveva, parlava, si baciava, discuteva. I ricordi catturati da Bedont ne fanno quasi un’agorà, di quella rampa: «A volte – dice una delle voci ascoltate dal regista – andavi lì sapendo che trovavi persone con cui passare la serata». «Quando dovevi entrare – dice un altro – poteva capitare che ci impiegavi mezzora per scendere le scale, tanta era la gente che incontravi e che salutavi». E poi i muri che sudavano per quell’impasto di umidità e fumo (ancora si poteva fumare all’interno dei locali pubblici) che rendeva le serate piacevolmente sfinenti.
Ha perso la città
«I locali modaioli, frequentati solamente da bellezze tutte uguali»
Niccolò Fabi, Ha perso la città
Ok. Chi aveva vent’anni negli anni novanta del novecento e frequentava il Norman può ritrovare il suo personale orgoglio nel constatare, da una prospettiva storica, che quel periodo non era così buio come si pensava vivendolo, che la storia non era finita e lo si dimostrava vivendola. Ma il significato delle cose di cui parlavamo all’inizio sta in altro. Perché Bedont, che ha ventisette anni oggi, si è sentito solleticato dalla storia del Norman? E perché trentenni come Andrea e Ivan Frenguelli si sono presi la briga di andare a dissotterrare la storia dell’ex Cim? Ecco. I due documentari sono come dei testimoni di un filo che lega i giovani dei novanta che animavano l’ex Cim e il Norman a una parte dei giovani e meno giovani di oggi. L’unione sta nella mancata resa all’idea della fine della storia, ora e allora. I ventenni dei novanta davano vita a quei luoghi nella ricerca a volte perfino inconsapevole di altro rispetto ai consumi, alle mode e alla cultura maggioritari dell’epoca. Andrea, Ivan e Nicola sono rappresentanti della generazione successiva, che nei loro casi con maggiore consapevolezza cerca di tirare su la testa dalla palude e tenta a sua volta altro rispetto al conformismo dei locali modaioli, per utilizzare la metafora della melassa che ci avvolge utilizzata da Niccolò Fabi.
Nel corso di un incontro organizzato al cinema Postmodernissimo, che è stato culla ideale delle prime proiezioni dei documentari sull’ex Cim e sul Norman, Nicola ha spiegato così la genesi di “The story of Norman”: «Ero a cena a una sagra insieme a degli amici vicino a Boneggio (la località in periferia di Perugia dove sorgeva il Norman, ndr) e mi sono chiesto: ma che fine ha fatto il Norman?». Ivan invece, allo stesso incontro, ha illustrato così i motivi che hanno spinto lui e Andrea a girare “Ex Cim – Mattone su mattone”: «Volevamo testimoniare che c’erano pratiche sociali che hanno generato a loro volta una serie di conseguenze».
E c’è un ulteriore filo che tiene insieme i ventenni dei novanta, i documentaristi di trent’anni dopo, l’ex Cim, il Norman e le varie esperienze più o meno analoghe passate e presenti sparse in tutta Italia. È rappresentato dalla forza della autenticità. Dal bisogno mai sopito di cercare spazi di manovra sottratti alle rigidità imposte. Laddove imposizione non è da ritenere come violenza, ma come pesante moral suasion, come invito implicito ad inibirti di fare altro che non sia il consentito che è rappresentato dalla macchina da guerra che abbiamo intorno e che batte tutti i giorni su un concetto tossico: non si può fare se non così, non c’è alternativa. Che è come dire che la storia è finita con altre parole. Quel filo lega i vari soggetti alla ricerca di alterità al di là degli spazi, dei tempi e delle generazioni. Lo dimostrano da ultimo queste opere e il successo che ha accolto le loro prime, entrambe avvenute con quattro proiezioni a sale gremite. Un filo che si nutre di un altro elemento: chi rifiuta le rigidità imposte non vuol imporre a sua volta rigidità. Cerca comunità. Non a caso tanto l’ex Cim quanto il Norman sono stati luoghi di sperimentazione autentica, di relazioni tra pari, di creazione di comunità. Come ha detto Angela Giorgi, dell’associazione Start, all’incontro in cui sono stati messi in parallelo i due documentari: «Oggi la condivisione rischia di essere solo quella dei post, qui si condivideva altro». L’autenticità, appunto. Che fa a pugni con la rigidità. Soprattutto quella imposta.